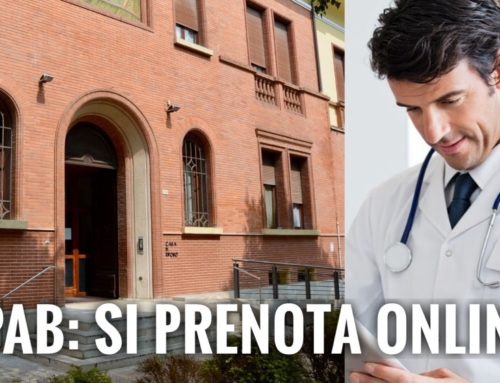Premessa.
Questa è una storia che non potete non leggere. È un po’ lunga, 9 minuti il tempo di lettura, ma la berrete tutta d’un fiato, perché è vera e bella.
Il primo virus proveniente dalla Cina che Cristian Fracassi ha visto in azione nella sua vita non è stato il coronavirus SARS Cov2, ma la delocalizzazione: quella smania di andare a far fare tutto in Cina che aveva contagiato un po’ tutti a cavallo del nuovo millennio, «perché costava meno», e che aveva prima messo in crisi e poi chiuso le due piccole fabbriche di tessuti dei suoi genitori. E forse in quell’episodio di venti anni fa si può rintracciare il senso di questa fiaba, la storia di un giovane ingegnere che nel bresciano, quando il Covid-19 dilagava negli ospedali e i morti li portavano via con i camion, ha stampato nel suo laboratorio prima un centinaio di valvole respiratorie, visto che erano finite e chi doveva produrle non riusciva a soddisfare la domanda; e poi ha modificato una banalissima maschera da snorkeling, di quelle per andare a vedere i pesci nuotando sul pelo dell’acqua, per farne un dispositivo medico, una maschera respiratoria da collegare all’ossigeno, di fatto inventando uno strumento nuovo replicato con successo dai maker di tutto il mondo per salvare vite umane.
Lo hanno chiamato «l’angelo con la stampante 3D», «il maker samaritano», «l’eroe inventore». Ma sono tutte definizioni retoriche che non raccontano davvero la formidabile storia di Cristian Fracassi. Eccola.
«Sono nato a Manerbio il 27 marzo 1983, una domenica. Era il giorno di Pasqua ma non mi chiamo Cristian per questa coincidenza, il nome era già stato scelto. I miei genitori, Renato e Letizia, erano due piccoli imprenditori del bresciano. Si erano conosciuti una sera in discoteca, si erano innamorati, sposati e avevano aperto una azienda a testa, una davanti all’altra. Nel settore tessile. Una faceva cucito, l’altra stiro. Abitavamo a Massano Bresciano, millecinquecento abitanti, operosi di natura e per tradizione. In quella zona c’erano tantissime piccole aziende tessili che lavoravano per la Marzotto. Io sono cresciuto nelle piccole fabbriche dei miei genitori. LERA Confezioni quella di mamma, si chiamava così per le iniziali del suo nome e delle tre sorelle Elisabetta, Rosa e Assunta: si occupava di creare gonne, vestiti, maglie, partendo da tessuto, lampo e bottoni. Quella di papà era Erika Confezioni, il nome della mia sorellina, a papà non gliel’ho mai perdonato… e si occupava di stiro, arrivavano i vestiti fatti da mamma e lui li stirava, impacchettava e li metteva sulle grucce, pronti per essere venduti».
«La mia culla era nei tessuti, i miei primi giochi erano i bottoni, sono vissuto col rumore delle macchine che cucivano, ero iper innamorato delle aziende…. Giocavo e vivevo in azienda. Con mia sorella quando siamo cresciuti ci muovevamo sui pattini tra le macchine che filavano e cucivano. Era il mio paradiso. I miei cucivano abiti da 4 o 5 mila lire che venivano venduti in negozio a 100 mila: mi sembra assurdo oggi che per risparmiare pochi centesimi in Cina, tutte queste aziende siano andate perdute. Non è successo all’improvviso, come con il coronavirus, ma comunque è stato un processo piuttosto rapido. E’ iniziato a mancare il lavoro, papà è stato bravo, ha provato a resistere, andava a cercare clienti in province diverse, viaggiava tanto per cercare nuove opportunità. Ma non ce l’ha fatta. Non era colpa sua: a un certo punto è fallito persino il Gruppo Manerbiesi che era un colosso che fatturava miliardi. Quando Lera ed Erica hanno chiuso, mamma si è messa a fare la casalinga, papà si è trovato un impiego come guardia in una azienda. Per me è stato un colpo, era il 1997. O il 1998».
«Io andavo alle medie allora. Ero un ragazzino iper timido e per questo ne prendevo un sacco. Sì, di botte. Già alle elementari mi picchiavano e io stavo zitto, non ero un ribelle. Cercavo di sopravvivere. Vivevo in un mio mondo che era più grande e più interessante dei bulli di classe. Ero curiosissimo, volevo sapere tutto, imparare tutto. Mia nonna Lina mi chiamava Mike Bongiorno perché facevo a tutti mille domande, all’epoca non c’era Google dove trovare le risposte, e io ero un tormento, lei diventava matta. A scuola sono sempre stato bravo, soprattutto in matematica. I miei genitori avevano scelto un istituto di suore, non perché fossero così religiosi, ma perché loro lavoravano, c’era il lungo orario e così uscivo nel pomeriggio con i compiti già fatti. Ma a quel punto per me iniziava il divertimento: c’erano l’orto e le galline con cui giocare, mi divertivo con ogni cosa, persino a raccogliere i pomodori».
«Quando ero piccolo il mio sogno era lavorare nelle aziende miei genitori. Lì nasce la mia passione per i macchinari. Papà era super tirchio. E visto che si era stancato di pagare tanti soldi a quelli che venivano a fare manutenzione in fabbrica, ma anche i lavoretti in casa, si metteva accanto a loro per imparare quello che facevano, e dopo un po’ era in grado di ripararle da solo. Quando lo faceva mi diceva sempre: ‘Vieni a darmi una mano!’. E’ stata quella la mia scuola più grande: ho imparato come funzionano le macchine, ma anche a levigare i mobili, o restaurarli. Fare le cose, costruirle, aggiustarle è stato il vero terreno di contatto con mio padre: negli anni abbiamo creato insieme oltre cento bonsai. I veri bonsai non si comprano, si fanno. Ci vogliono da 5 a 20 anni per ottenerne uno. E’ un’arte, qualunque pianta può essere un bonsai, tenendola in un vaso piccolo, si ridimensiona, produce foglie e frutti piccoli, invecchia piccola. Io temevo di essere un bonsai. Fino a 18 anni ero alto un metro e mezzo, ero il nanetto della classe. Poi in una estate, quella di quinta, sono cresciuto di 28 centimetri. Oggi sono alto un metro e 78: non ho fatto nessuna cura particolare, semplicemente sono a scoppio ritardato».
«Gli anni del liceo mi avevano portato per la prima volta fuori dal mio paesino natale: andavo allo scientifico di Manerbio, che ha 13 mila abitanti ma mi sembrava una metropoli. Avevo dei prof cattivissimi ma sono quelli che mi hanno fatto innamorare delle loro materie: in particolare mi ricordo Cominelli, che insegnava arte e architettura, e la Gobetti che mi bastonava in matematica. Faceva bene però. Infatti a 18 anni sono diventato campione italiano di matematica. E’ accaduto per caso, o quasi. Insomma la storia è questa. Nonostante la timidezza, amo le sfide e le competizioni. E’ il mio modo per superarla».
«Ricordo che alle finali provinciali mi accompagnò papà: dopo il test, in attesa dei risultati, mi disse: andiamo a trovare il nonno. Facemmo tardi ed era ora di tornare a casa ma gli chiesi di andare lo stesso a vedere come ero arrivato. Tutti stavano uscendo ormai, noi ci presentammo al banco della giuria, dove c’era rimasto un tale, al ché chiedo: come sono arrivato? Mi chiamo Fracassi, Cristian Fracassi. E quello urla: abbiamo trovato il primo classificato!!! Avevo vinto. Il primo premio era un personal computer, ma visto che non mi ero presentato lo aveva già ritirato il secondo classificato. Ne ho dette un sacco al mio papà che però ha reagito in modo strano: non mi ha neanche regalato l’orologio che mi aveva promesso in caso di vittoria».
“Tre settimane dopo c’erano le finali regionali a Milano: andammo tutti in pullman, io ero l’unico senza genitori: dove vuoi andare, tanto non puoi vincere, mi aveva detto papà. Ma devo spiegarlo meglio: papà è sempre stato orgogliosissimo di me, ma non me lo voleva dire. Ai tempi per questo lo detestavo, e questa è stata la grande molla per migliorarmi sempre e dimostrargli che si sbagliava; solo adesso capisco che lo faceva apposta per spronarmi, per farmi tirare fuori il mio talento. Per accendere il mio orgoglio. Ha fatto bene. Infatti quell’anno ho vinto le regionali a Milano e le finali nazionali a Cesenatico. Da solo».
«Ero indeciso fra ingegneria e architettura e optai per una laurea doppia, a Brescia. Tutto cambia durante l’ultimo anno di università. Era il 2009 e c’era stato il terremoto dell’Aquila. Ricordo quel pranzo in casa con la tv accesa a guardare le case demolite con il groppo in gola. Pensavo: è colpa nostra, abbiamo sbagliato i calcoli per rendere quelle case sicure. Mi faceva rabbia vedere la gente disperata e non poter aiutare: non saprei fare altro che spostare macerie, pensavo. Il giorno dopo all’università vedo un camioncino che porta casse d’acqua, di plastica. E mi viene l’idea di creare mattoni di plastica che si incastrano facilmente. Era una follia, non avevo nemmeno le competenze. Allora decisi di farci la mia tesi di laurea. Scoprii così che in Germania, dopo la guerra, molti avevano fatto case di plastica. Erano case di forme strane, una moda che durò poco, ma quella tecnica era poi servita per costruire componenti dell’industria delle automobili e in particolare i camper. Così mi imbattei nel progetto della “casa non costruita” di Mies van De Rohe, un progetto del 1951 per una edilizia di massa che però non stava in piedi: pensai di ricostruirla in mattoni di plastica. I calcoli mi davano ragione: si poteva fare!».
«Dovete capire che per fare mattoni in plastica non esistono neanche le norme tecniche. Allora decisi di impiegare i mie tre anni di dottorato in ingegneria dei materiali per studiare i polimeri. Volevo sapere tutto sulle plastiche. Li ho trovato un ottimo maestro: Giorgio Ramorino. Come studio di dottorato presentai un progetto per l’utilizzo strutturale dei polimeri mentre di notte studiavo come fare il mio mattoncino: dopo tre anni era bello e finito. Il mio mattone. A Brescia ci sono tante aziende che stampano plastica, non è una roba strana, così ho pensato di cercare un imprenditore che finanziasse il progetto. Ma cadevo sempre sulla seconda domanda: la prima era, quanti soldi ti servono? La seconda: quando me li ridai? Non lo sapevo, non sapevo nulla di economia. Ero una capra. Lì ho capito che avrei dovuto studiare. L’associazione imprenditori bresciani organizzava un master, gratuito per i primi dieci: sono arrivato primo, ho preso la borsa di studio e così ho imparato come si sviluppa il business di una idea».
«Abitavo ancora a casa dai miei genitori. Papà era severissimo. Prendeva i soldi delle mie borse di studio e me li decurtava perché diceva che abitavo da loro. D’estate per guadagnare qualcosa facevo il giardiniere, le piante mi sono sempre piaciute. Ma tutto stava per cambiare. Partecipo ad un concorso di idee della Camera di commercio di Milano: mi ero inventato una pallina di plastica dentro un cubetto di ghiaccio, per capire se un alimento era stato scongelato nel tragitto fino al negozio. Vinco il primo premio, cinquemila euro: volevo finalmente comprarmi la mia prima automobile, visto che avevo 29 anni, ma decido invece di usare quei soldi per depositare il mio primo brevetto. Due giorni dopo mi chiama un imprenditore locale e me lo ricompra per 14 mila euro. Si chiama Alvise Mori, diventerà il mio testimone di nozze ed è la persona che mi ha cambiato la vita: assieme fondiamo Isinnova, Inventa Sviluppa e Innova, la nostra azienda per sviluppare idee nuove. E’ l’ottobre del 2014. Sei anni dopo sarà Isinnova a salvare la vita a migliaia di pazienti di Covid-19».
«A Isinnova usiamo il digitale, ma per fabbricare oggetti. Non facciamo siti o app, con le stampanti 3D e con altre strumenti di fabbricazione digitale, arriviamo a realizzare prodotti finiti. In un certo senso io resto un meccanico, faccio cose da toccare. Realizzo invenzioni. E veniamo al motivo per cui siamo qui a parlare di me. Era un venerdì 13, venerdì 13 marzo e l’Italia intera era in lockdown da qualche giorno. I miei dipendenti erano a casa in smart working e io ero nel nuovo ufficio di Isinnova, ero lì che pulivo e pitturavo le pareti. Mi chiama la direttrice del Giornale di Brescia, Nunzia Vallini: dice che la situazione è drammatica, all’ospedale di Chiari servono valvole respiratorie, “hai una stampante 3D?”. Io ne ho 6. Ma per stampare serve il progetto della valvola, per poter impostare i comandi. Quella valvola in particolare la produce una multinazionale, li chiamo, mi rimbalzano da un responsabile all’altro, fino al Lussemburgo. Capisco che se vado in ospedale a prenderne una faccio prima».
«Scopro così che non si tratta di un oggetto semplice, e in più ha un foro da 0,6 millimetri, poco più grande di un capello, dove passa l’ossigeno. La disegniamo in 3D, decidiamo di non stampare il foro e lo facciamo a mano, con una micro fresa, roba da orologiai. Il giorno dopo, era sabato portiamo le prime 4 valvole in ospedale per un test; dopo un po’ un medico esce dal reparto e ci dice: funziona, portatemene altre 100. La mattina seguente l’ospedale aveva le valvole richieste, rifinite a mano. Sembra un miracolo ma non lo è: la storia fa il giro del mondo, qualcuno scrive che la multinazionale vuole farci causa ma non è vero, anzi ci ha chiamato per ringraziarci; e non è neanche vero che abbiamo rifatto delle valvole da 10 mila euro con 1 euro di materiali ciascuna, nel prezzo di un oggetto non ci sono solo i materiali, c’è il lavoro, l’idea, la distribuzione… L’ho imparato al master».
«Torno a casa felice: adesso quarantena per tutti, dico ai miei collaboratori. Ma nel pomeriggio ricevo un’altra telefonata dal Giornale di Brescia: c’è un medico in pensione che vorrebbe parlarti, mi dicono. Si chiama Renato Favero. Ci incontriamo lunedì mattina. Mi dice: bravo per le valvole, secondo me a breve mancheranno anche la maschere respiratorie. La sua idea è convertire una maschera da snorkeling. Mi fa tre ore di lezione sul funzionamento dei polmoni. Ha ragione, si può fare. Ma dove trovare le maschere in grandi quantità? Chiamo Massimo Temporelli, un esperto di innovazione, che contatta Decathlon. La risposta è incoraggiante: in magazzino ne hanno 100 mila, solo in Italia, per la stagione estiva. Ci forniscono la scheda tecnica del prodotto e ci mettiamo a modificarne una: i test stavolta sono durati un paio di giorni, non solo a Chiari ma anche a Brescia. Ricordo il medico che esce con il responso. Dice: Cazzo!, e io penso al peggio, mi sento crollare, ma poi aggiunge, ‘Funziona!’».
«Con Favero siamo corsi a registrare il brevetto, non per guadagnarci, ma per proteggerlo: lo possono usare tutti, ma non per profitto. La maschera modificata l’abbiamo chiamata Charlotte, in onore di mia moglie Carlotta: ci siamo conosciuti 5 anni fa, è stato un colpo di fulmine, lei mi ha sempre spalleggiato, anche se la sera quando tornavo a casa durante la quarantena mi faceva spogliare fuori di casa per timore di contagi».
«Decathlon ha regalato migliaia di maschere in tutto il mondo ma si può ottenere lo stesso risultato anche con maschere di altri produttori. Nel mondo in tantissimi hanno scaricato il nostro file di progetto e hanno fatto lo stesso. Ricordo un messaggio che mi è arrivato da un dottore in Brasile: oggi cento persone respirano grazie a te. Ci hanno chiamati eroi ma siamo eroi passeggeri, fra poco in prima pagina torneranno i calciatori. Non importa, sono contento così, ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque. Ho fatto quello che so fare».
«Quando il mio nome era sui giornali di tutto il mondo mi è arrivato un messaggio Whatsapp che aspettavo da tutta la vita. ‘Sei un genio’ c’era scritto. Dal mio papà. Era il secondo messaggio che mi scriveva in tutta la mia vita. Il primo quando mi sono laureato: su un biglietto di carta, ci ha scritto ‘ti voglio bene’. E’ ancora nel mio portafoglio. Visto che è orgoglioso di me?».
Il 3 giugno 2020 tra i Cavalieri della Repubblica nominati dal presidente Sergio Mattarella c’era anche il 37enne bresciano Cristian Fracassi, che nel suo laboratorio ha progettato e stampato dispositivi medici per l’emergenza coronavirus, con lui anche il primario in pensione Renato Favero.
[Repubblica.it] Questa storia è stata scritta per la rivista Aspenia.
Foto:a sinistra, Cristian Fracassi con la maschera da snorkeling; a destra in alto, il primario Renato Favero e Cristian Fracassi; in basso, Fracassi durante un test del suo respiratore anti Covid.